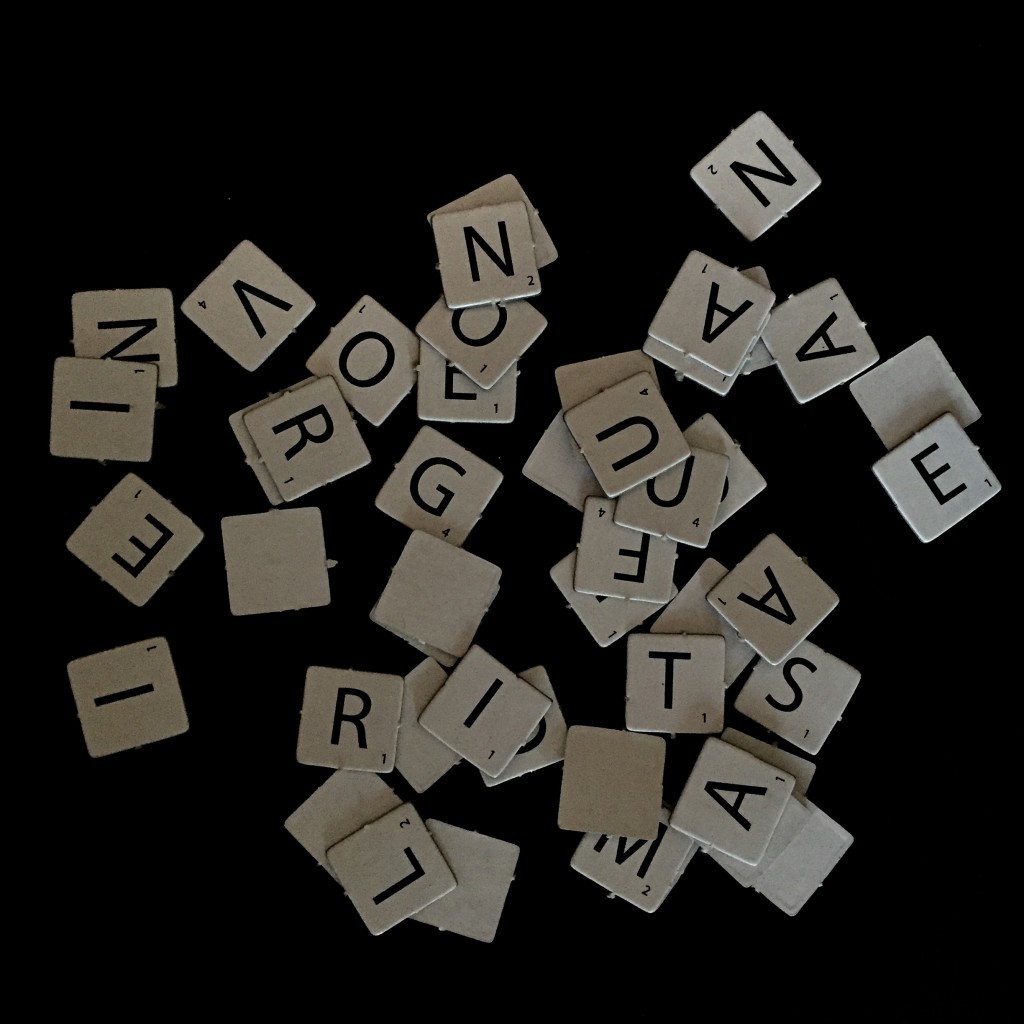
Vi sarete accorti quanto mi piaccia partire da lontano per afferrare un concetto e proporre una riflessione. Ecco, oggi, il mio “viaggio” inizierà da uno dei luoghi che ho più amato: l’Islanda.
Tempo fa, leggendo i saggi di Jeorge Louis Borges contenuti nella raccolta Storia dell’eternità (ed. Adelphi, 1997), appresi dell’esistenza delle kenningar islandesi, ovvero, per citare il poeta e scrittore argentino, di quelle metafore o «formule enigmatiche» che rappresentano il «primo deliberato piacere verbale di una letteratura istintiva”. Fu Snorri Sturluson – identificato da Borges quale «noto storico, archeologo, edificatore di terme, geneaologista, presidente di un’assemblea, duplice traditore, decapitato e fantasma» – a fornire un’iniziale compilazione delle bizzarre figure retoriche di cui traboccano i poemi epici scaturiti da crepacci e vulcani.
Riporto alcuni esempi, estrapolandoli qua e là: il braccio è definito “gamba della spalla”, il cielo diventa la “tazza dei venti”, il cuore la “dura ghianda del pensiero”, il mare “tetto della balena” o “prato dei gabbiani”, il petto “dimora delle risate” e così via. Insomma, un acrobatico tripudio di fantasia che merita di esser conosciuto.
Fatto sta che, in virtù di un abbinamento che riconosco essere azzardato, le kenningar mi rimandano ogni volta ai titoli posti a corredo di certe fotografie d’inizio Novecento.
Uno fra tutti? Candida brina mesta regina, titolo che il fotografo torinese Guglielmo Oliaro diede a un suo paesaggio premiato nel 1907 dalla Società Fotografica Subalpina e titolo, fra l’altro, di uno dei capitoli del libro «La Fotografia Artistica» 1904 – 1917 / Visione italiana e modernità (ed. Bollati Boringhieri, 1990), scritto dal compianto Paolo Costantini.

Candida brina mesta regina, dunque. A qualcuno vien da sorridere nel leggerlo? Io non lo farei. Detto questo, non voglio sostenere che in un secolo poco sia cambiato, ma certo ancora molto «s’ha da fare» in materia di titolazione. Si sa che la lingua italiana, contrariamente all’idioma islandese mai variato nel corso dei secoli, è duttile e sensibile ai cambiamenti e alle colonizzazioni. Tuttavia, nel nostro Paese, gli infervorati rigurgiti di contemporaneità non si sono dimostrati impermeabili all’oleografia o al provincialismo.
Intanto, anche se – e sottolineo se – un titolo evocativo funzionasse per un’intera serie, difficilmente la stessa cosa varrebbe per le singole fotografie. Non dovremmo mai dimenticarci, infatti, che ciò che è contenuto tra i bordi di un’inquadratura è, in buona sostanza, ciò che ci serve: non abbiamo alcun bisogno di invocare ectoplasmatiche presenze dall’aldilà del fuori campo, non tanto visivo quanto concettuale.
Una rondine non fa primavera, un anziano non fa solitudine, per intenderci.
Vogliamo commentare i titoli in inglese? Beh, certo i photographer, hanno “acca” da vendere, un magazzino pieno, mi vien da pensare. Invece, chi si occupa di project ha i serbatoi colmi di “i lunghe”.
Capisco, o mi sforzo di capire, ma non sempre l’ammmerica (sì, con tre “emme” e lo zio miliardario pronto a “sganciare” l’eredità) è lì ad aspettarci e allora, forse, meglio non ammalarsi di entusiasmo. Meglio non esser né affrettati, né affettati. Meglio pensare. Pensare a chi è diretto un lavoro, a chi lo guarderà realmente, a chi dovrà interpretarlo proprio a cominciare dal titolo. Amiamo giocare con le lingue? Facciamolo con tutte. Usiamole, quando serve, ma non limitiamoci a una. Oggi inglesi, domani italiani, poi francesi, greci e giapponesi, cittadini del mondo intero. Non vogliamo rinunciare a essere international? Bene, anzi giusto: abbiamo la possibilità di creare siti bilingue, accessibili tanto ai nostri connazionali quanto ai nostri estimatori stranieri.
Già che ci siamo, ricordiamoci, inoltre, che Senza titolo non è una scorciatoia, ma un titolo a tutti gli effetti e che contiene, pertanto, un’indicazione ben precisa per il fruitore.
Non dimentichiamo, neppure, che un titolo non è una didascalia, ma è una parte di essa, insieme con il nome e cognome dell’autore, il luogo e la data di produzione.
Non vi ho convinti? Pazienza. Per tornare alle kenningar e concludere, io, con “la mela del petto” (1) e fuori dalle “rocce della parola” (2), vi ho invitato a usare la “rupe delle spalle” (3) . Alla peggio, leggendo l’ennesimo artificio linguistico, esclamerò: che “foresta del mento” (4)!
Note
1. cuore
2 .denti
3. testa
4. barba
![© Stefano Ghesini Salvadori, "Non tutta la meraviglia..." [particolare dell'installazione a cielo], 2017](http://www.lauramanione.it/wordpress_it_IT_4_2_2/wp-content/uploads/2017/03/mjhiondkpodnfllo.jpg)



