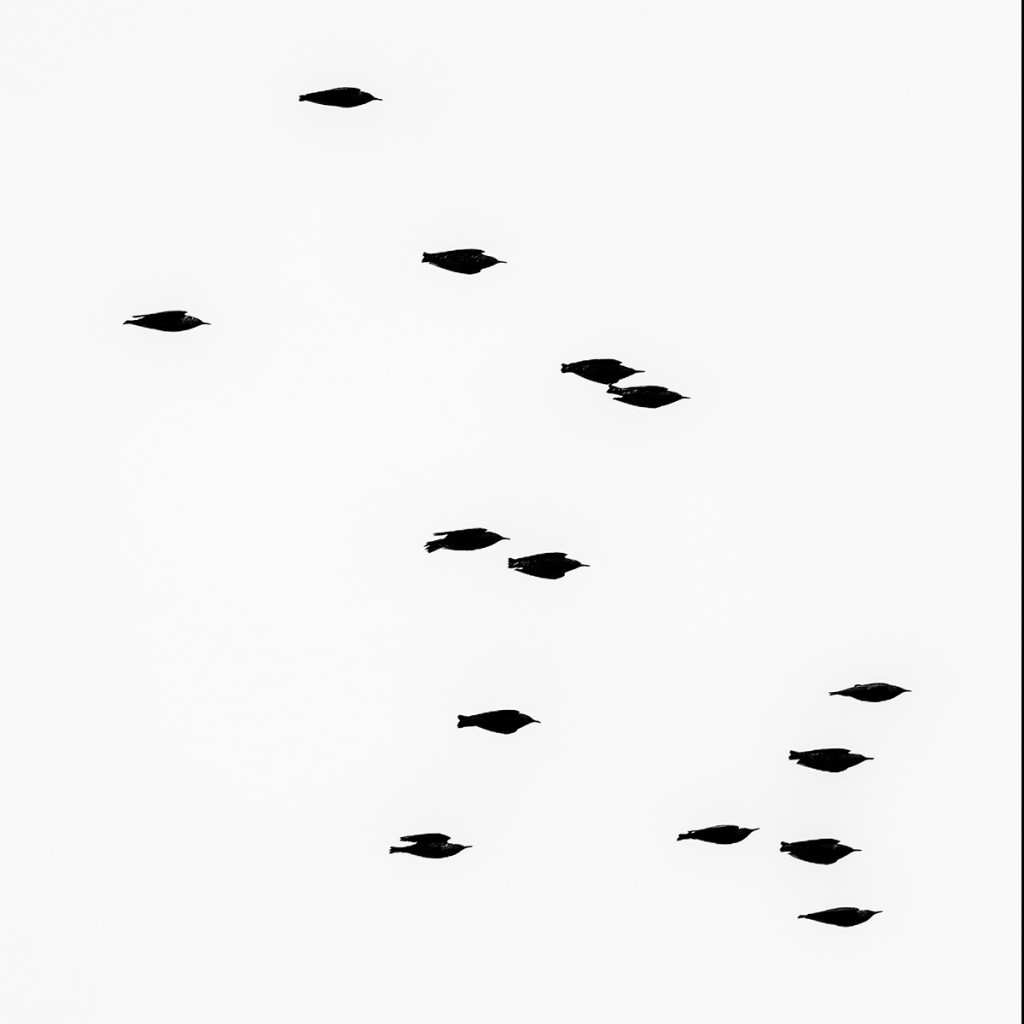In un’intervista rilasciata nel 2007, Roni Horn, artista che apprezzo molto, dichiarava: «Il tempo è una parte importante della nostra vita. È costante nella sua indifferenza nei nostri confronti e comunque imprevedibile, fa sì che tutte le circostanze siano complesse e che in definitiva sfuggano al nostro controllo. A me pare sia essenziale avere qualcosa che ci dice chi siamo, e il clima ha un suo modo per fare proprio questo. Ho sempre preso il tempo meteorologico in modo molto personale. Freud dice che “parlare del tempo è parlare di se stessi”. E io sono attratta dal tempo tanto per quello che è in sé, quanto per ciò che la gente ha da dire a suo riguardo. La bellezza del tempo è che tutti lo condividiamo equamente, e in questo momento nella nostra storia potrebbe trattarsi dell’unica cosa che abbiamo in comune».
Per ciò che mi riguarda, la citazione lucida ed esauriente della Horn, con cui sono in pieno accordo, sarebbe sufficiente a chiudere questo articolo, ma voglio concedermi lo spazio per un’ulteriore digressione foto-meteorologica.
Al di là dei lavori di autori molto conosciuti, che già fornirebbero esempi soddisfacenti, chiunque pratichi i social e osservi il flusso di immagini che li invade, sa che esiste una sorta di stagionalità fotografica a cui pochi sfuggono. Le prime nebbie e la prima neve sono declinate in ogni maniera, così come l’auspicato apparire del sole primaverile, seguito dalle piogge insistenti che sembrano invece tardare l’arrivo dell’estate, dall’immobile canicola di luglio, dai temporali ferragostani e via dicendo, con circolarità.
Il tempo ci spinge a scattare immagini e, di conseguenza, se ben approcciato, potrebbe essere il grimaldello per aprire stanze più intime di noi stessi, abitate da umori, storie e desideri.
Tornando ai nomi noti, sussistono campioni di raro incanto legati alle condizioni meteorologiche, basti pensare, fra tutti, a The Magic Garden during a Summer Shower[Acquazzone d’estate nel giardino incantato] di Joseph Sudek, che confesso essere tra le mie fotografie preferite in assoluto.

Ciò che però mi pare più significativo, in un’ottica squisitamente fotografica, è che esista una sostanziale differenza tra il modo di percepire il tempo tra Occidente e Oriente, differenza che ha indubbie ricadute sulla produzione delle immagini.
Ho avuto modo di approfondire l’argomento durante la preparazione del mio laboratorio “Fotografie in forma di haiku”, tenuto lo scorso anno, ma siccome ogni laboratorio è un working progress, ora mi sento di aggiungere una postilla che mi auguro possa essere di qualche interesse.
I giapponesi hanno stilato, nei secoli, un rigoroso lemmario con vocaboli pescati dal serbatoio naturalistico-meteorologico, la cui presenza all’interno di uno haiku, denominata kigo o piccolo kigo, svolge la funzione prestabilita di fornire al lettore un rimando a una delle quattro stagioni. Alla primavera appartengono lo sciogliersi della neve, lo zefiro, la pioggerellina; all’estate il sole di mezzogiorno, la foglia bruciata dal sole, la calura; all’autunno il vento, la nebbia; all’inverno la neve o la tormenta.
Ora, vi sono fotografi occidentali che espressamente si sono ispirati a quei “lievi coaguli di versi”, come li definiva Andrea Zanzotto, per realizzare le loro immagini: da Stieglitz a Weston, da Minor White a Vimercati, per citarne alcuni, ma restano comunque casi isolati, mentre per gli autori nipponici il tempo è quasi sempre – in linea con la loro tradizione poetica – uno stato impermanente e fluttuante ma indiscutibile, un presupposto da accettare, dal quale farsi sorprendere e con il quale far collimare un altrettanto mutevole paesaggio interiore.

Al contrario, per noi, più che i fenomeni atmosferici in sé, hanno progressivamente acquisito più importanza le previsioni metereologiche. Prevedere significa affidarsi a un’ipotesi di futuro basata su degli indizi, come ci insegna il dizionario, ma pre-vedere, per chi pratica la fotografia, potrebbe significare anche preparare lo sguardo, prefigurarsi un’immagine.
Un’azione utile? Nel caso specifico, penso di no. Meglio meravigliarsi, non sapere se domattina pioverà o ci sarà il sole, ma affidarsi al caso, ammettere, insieme con Roni Horn, che qualcosa può e deve sfuggire al nostro controllo. Meglio amplificare le nostre capacità sensoriali durante esperienze dirette e inattese, approfittando delle condizioni climatiche, variabili e incostanti, per raccontare, con la fotografia, la caducità e la capacità di rinnovamento che ci rendono umani.
Forse, con il disgelo, come recita uno haiku di Natsume Sōseki (1867-1916), finiremmo per afferrare la grazia di «Poter rinascere/piccolo…/Pari a violetta».